Nuova analisi di F. Gregory Gause, III* per il Brookings Doha Center
 Pubblichiamo una libera traduzione del sommario del BROOKINGS DOHA CENTER ANALYSIS PAPER n. 8 di settembre 2013. Il tema delle Monarchie arabe, delle loro diversità tipologiche, delle differenze rispetto ai regimi repubblicani dell’area e del loro approccio verso le rivolte che hanno sconvolto molti Paesi arabi spingono islamicwold.it a presentare questa analisi come un importante contributo al dibattito internazionale sulle realtà politiche che guidano le popolazioni musulmane di quell’area. Le interpretazioni, come è ovvio, rappresentano la visione dell’autore e non coinvolgono necessariamente “in toto” l’approccio di questa pubblicazione.
Pubblichiamo una libera traduzione del sommario del BROOKINGS DOHA CENTER ANALYSIS PAPER n. 8 di settembre 2013. Il tema delle Monarchie arabe, delle loro diversità tipologiche, delle differenze rispetto ai regimi repubblicani dell’area e del loro approccio verso le rivolte che hanno sconvolto molti Paesi arabi spingono islamicwold.it a presentare questa analisi come un importante contributo al dibattito internazionale sulle realtà politiche che guidano le popolazioni musulmane di quell’area. Le interpretazioni, come è ovvio, rappresentano la visione dell’autore e non coinvolgono necessariamente “in toto” l’approccio di questa pubblicazione.
Nessuna monarchia araba è caduta durante le Rivolte arabe e solo una – il Bahrein – ha avuto una crisi che ha scosso il regime. Questi regimi, sminuiti per decenni come anacronismi, hanno resistito alla bufera politica della regione meglio dei loro vicini repubblicani. Le relative reazioni accademiche e degli esperti, però, sono state fuori luogo. Affermazioni che le monarchie siano unicamente e intrinsecamente più stabili o che, all’altro estremo, la loro caduta sia solo questione di anni travisano la situazione. Le monarchie arabe perdurano per ragioni un po’ più prosaiche.
La vera storia della longevità monarchica durante la Primavera araba riguarda le strategie che questi regimi hanno utilizzato per rimanere al potere. Le monarchie sono, infatti, po’ diverse dagli altri regimi autoritari che operano per garantire la propria sopravvivenza. Le pretese circa la particolare legittimazione culturale delle monarchie arabe tendono ad essere antistoriche e ripetitive e c’è poco da proporre sulle prestazioni superiori di questi sistemi. Piuttosto, le monarchie arabe hanno dispiegato la loro ampia ricchezza di idrocarburi per smussare la richiesta popolare di riforme; anche i regni che al confronto sono poveri di risorse sono stati sostenuti dai loro alleati più ricchi. E ogni monarchia araba per sostenere la stabilità del regime ha mantenuto una potente coalizione di supporto di gruppi di interesse nazionali, di alleati regionali e (tipicamente occidentale) di protettori stranieri.
Naturalmente, i particolari di questa comune strategia differiscono da Paese a Paese, così come la natura delle monarchie stesse. Le monarchie arabe possono essere meglio comprese se riferite a due tipologie istituzionali. In Marocco e Giordania i re regnano in quanto individui. Negli stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo, sono le famiglie estese che governano; in queste monarchie dinastiche i monarchi sono parte di un più ampio organo di governo collegiale (l’Oman si trova invece a cavallo di questa dicotomia). Questa distinzione ha contribuito a determinare la reazione delle monarchie alle rivolte della regione – per esempio, è più difficile per un re licenziare un primo ministro quando è suo cugino – così come alle possibilità di riforma.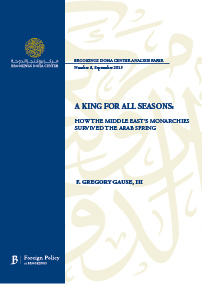
Tutti i monarchi hanno avvertito nuove pressioni per la riforma politica in senso democratico. L’ondata democratica globale degli ultimi 30 anni è da ultimo arrivata nel mondo arabo, sostenuta in parte dalla crescente accettazione da parte di molti islamisti della democrazia come sistema preferito per uno stato islamico. Anche le monarchie che hanno resistito così tanto e con successo alla riforma si trovano di fronte popolazioni sempre mobilitate. Un effetto dimostrativo regionale mette sotto pressione le monarchie arabe e la pratica della democrazia araba ha una risonanza particolare in alcune di queste società. La partecipazione democratica dei Salafiti, come il Partito Nour in Egitto, per esempio, può indurre proprio i Salafiti dell’Arabia Saudita ad abbandonare il loro quietismo politico e a mobilitarsi per un ruolo più attivo nella governance.
Eppure, questi regimi sono sostanzialmente stabili. Chi prevede l’imminente caduta delle monarchie arabe evidenzia vere contraddizioni e problemi all’interno di questi sistemi monarchici. Fallisce, tuttavia, nel dimostrare come queste sfide in realtà si traducano nel collasso di regime. Ogni generazione dal secondo dopoguerra ha sentito previsioni che l’Arabia Saudita non avrebbe resistito per molto tempo. L’ultima tornata di necrologi sembra ispirato dalle rivolte arabe, ma i problemi che gli analisti individuano esistevano da lungo tempo prima del 2011; se le monarchie erano pronte a cadere, perché non al culmine dell’instabilità regionale? Persino la monarchia del Bahrein, che è stata veramente scossa dalla mobilitazione popolare, è riuscita a sopravvivere. Delle minacce alla sopravvivenza delle monarchie più comunemente citate, solo un calo sostenuto dei prezzi del petrolio sarebbe veramente problematico.
Però, questo sembra lontano negli anni e anche in quell’eventualità gli immensi depositi di ricchezza delle monarchie probabilmente le sosterrebbero.
La sopravvivenza delle monarchie, specialmente nel mezzo di turbolenze regionali, dovrebbe essere considerata come un segno di forza, non di debolezza. È un indicatore che le loro risorse alla base della loro forza e controllo sono intatte – il che in fondo rappresentano buone notizie per gli Stati Uniti. Per la maggior parte, le monarchie condividono gli obiettivi della politica americana in Medio Oriente e collaborano con gli Stati Uniti su questioni militari, diplomatiche e di intelligence. Sono alleati vitali e affidabili.
Naturalmente, l’impegno retorico dell’America per la democrazia nella regione espone Washington alle accuse di ipocrisia sulle sue relazioni tranquillizzanti con i suoi alleati regali. Questa tensione è maggiore con le monarchie dinastiche che non con le monarchie individuali. Quando Washington parla di democrazia con i re di Marocco e Giordania, non è fondamentalmente minacciosa. Questi re possono fare, come hanno fatto, concessioni ai parlamenti eletti, senza sostanzialmente cambiare la natura dei loro regimi. Lo stesso non si può dire delle monarchie dinastiche. Quando gli Stati Uniti parlano di democrazia ai re di Arabia Saudita e Bahrein o all’emiro del Kuwait, stanno implicitamente dicendo che dovrebbero abbandonare i loro sostenitori primari – le proprie famiglie estese – e trasferire il potere a comuni cittadini eletti. È prevedibile che quelle stesse famiglie allargate possano resistere vigorosamente a questa sorta di cambiamento radicale.
La stabilità della regione, individuata come priorità dagli Stati Uniti, ha portato a supportare ciò che vedono quale migliore garanzia di lungo termine per questa stabilità: una graduale riforma democratica. Ma, nel breve termine, il cambiamento democratico può essere destabilizzante, come abbiamo visto in Egitto, Tunisia e Libia. Una vera e propria spinta americana per la democratizzazione nelle monarchie dinastiche potrebbe minare la stabilità che la regola della famiglia allargata ha dato a quei Paesi. Inoltre, in ciascuno di questi Paesi Washington ha un’agenda che va oltre la riforma politica interna; reali interessi legati al petrolio, la pace arabo-israeliana, la cooperazione militare e la condivisione dell’intelligence sono la posta in gioco. E come l’esperienza americana in Iraq insegna, le intenzioni americane possono differire radicalmente dai risultati effettivi delle azioni degli Stati Uniti. Siccome l’America lavora per promuovere la riforma politica in Medio Oriente, allora i fatti sostengono un molto cauto – e umile – approccio Paese per Paese con i suoi alleati monarchici arabi.
Per leggere il testo in Inglese: http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2013/09/24
* F. Gregory Gause, III è un membro anziano non residente presso il Brookings Doha Center. Si è specializzato in politica interna e relazioni internazionali dei paesi del Golfo, con particolare attenzione sull’Arabia Saudita. È autore di The International Relations of the Persian Gulf (Cambridge University Press, 2010). Attualmente è Professore di Scienze Politiche presso l’Università del Vermont.


